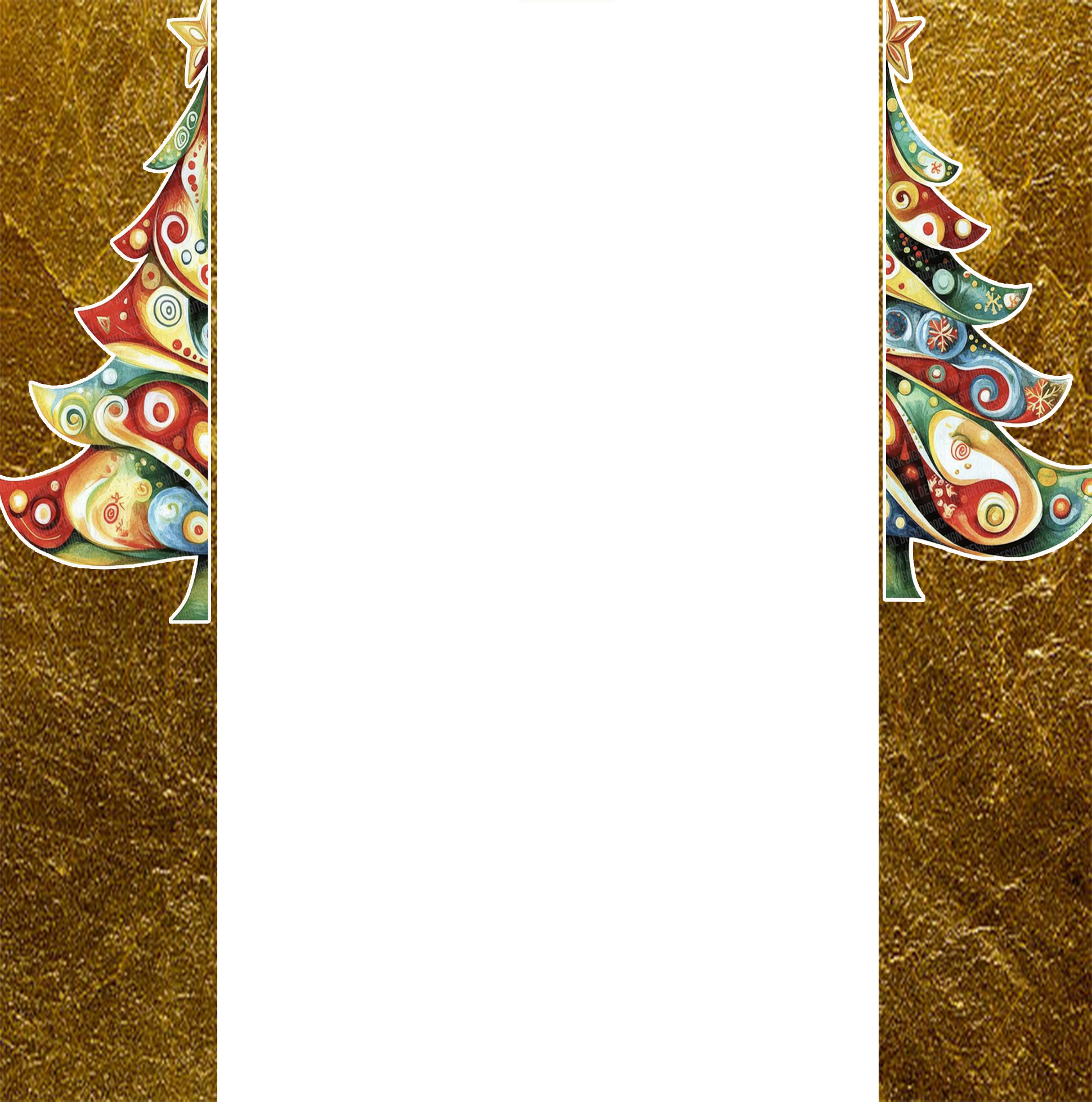Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme.
Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme. DIARIO (NOSTALGICO, UTOPICO E UN PO’ INCAZZATO) DI UN TERAMANO A LONDRA
di MORENO FIENI
 Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme.
Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme.
 Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme.
Il mondo deve essere pieno di nostalgici se, ai tempi dei megapixel, la bancarella più affollata a Portobello era quella delle vecchie macchine fotografiche. Non so se tutti quelli della mia età sono nostalgici delle figurine Panini dei calciatori, ma sicuramente dipingerà dolci ricordi quel “celo, celo, manca” che stava ad indicare incolpevoli sfighe nell’apertura di centinaia di bustine. Fra le mie mancanze, più o meno colpevoli, c’era la città di Londra, un po’ come la figurina di Maradona fra gli innumerevoli doppioni di Ciro Ferrara, con quel sorriso plastico che ad un certo punto non interessava più nessuno. Si perché senza nulla togliere né a Ciro Ferrara, né alle altre capitali mondiali, Londra possiede quell’unicità che la rende città troppo città, a voler parafrasare Nietzsche in chiave urbanistica. Le ciminiere. Non ho pretenziosità architettoniche, ma Londra è figlia di una rivoluzione tanto quanto Parigi, solo che a garantire liberté, fraternité ed egalité si rischia di non portare a casa lo sviluppo, che per quanto grigio di fumo e sporco di carbone, ha lasciato ovunque piccole, grandi e colossali canne fumarie, che sono monumenti dell’aver vissuto il proprio tempo, tanto quanto i reperimenti egizi del British Museum. Solo che a differenza di tante altre città non è solo quello, è come se non si fosse mai fermata, come se lo slancio ottocentesco, le conceda ancora oggi un allenamento invidiabile, come se la cara vecchia Londra, abbia ancora talmente tanto fiato da competere per il knock out senza le cinematografiche romanticherie alla Rocky Balboa e senza alcuna panteganesca Adriana da urlare. Anche perché, la voce di questa città è piuttosto quella di una moderna Babele, che trova la sua rappresentazione paradigmatica nella torre di radio installata alla Tate Modern, senza urla, senza casciara, un borbottio sommesso di interferenze linguistiche, perché ognuno si sente padrone della sua lingua rispetto all’universalità dell’inglese. Come se il suo idioma fosse la manopola del volume, in grado di controllare qualunque genere trasmesso, dal pakistano al teramano. Del resto se il gran Conte, sindaco se preferite, degli oltre 1500 kilometri quadrati della contea londinese è proprio di origine pakistana, qualche significato reconditamente cosmopolita, questa città dovrà pur averlo. Che sia grande, immensa, se ne accorgono i piedi ed i tendini, a pezzi dopo la prima giornata avida di scoperte, un quartiere tira l’altro, per immergersi in panorami che non hanno paragoni, con gli occhi spalancati a percorrere spazi inusitati che hanno il tempo di un paio di secoli, che congiungono le architetture ottocentesche ai ponti con il cielo di fine millennio, in una mescolanza di modernità che trova sì l’omologia delle grandi città ma al tempo stesso nessuna analogia di continuità. Piazzate un grattacielo a Roma, anche solo su un plastico, come quando si ragionava dello stadio della Roma e avrete la stessa urticante reazione bestemmiante che ebbe Sgarbi al limite di un ulteriore infarto per l’accanimento sulla capitale d’Italia. Invece i grattacieli a Londra non ingombrano, strizzano l’occhio alle canne fumarie dei boilers a carbone, si sfidano a darsi il cambio, recuperando le prime per guardare meglio i secondi, ti invitano all’invidia di avere un salottino a sbalzo in un appartamento al decimo piano, con vetrate che impongono cartelli con su scritto “per favore, rispettate la privacy dei nostri vicini” quando per me avrebbero dovuto scrivere “per favore, non rosicate sulla vita dei nostri vicini”, si adeguano all’idea di un mondo che va in alto quando c’è troppa necessità di vivere l’orizzonte dei luoghi e lascia ad enormi distese di verde la responsabilità della quiete e della qualità della vita. I parchi, a frotte, ettari su ettari di verde curato, con innesti di alberi e panchine da fare invidia alle nostre montagne, un cuore di ristoro dove persino i bambini e le mamme corrono con i passeggini, perché se c’è una cosa che non ho capito, è dove vadano gli inglesi con tutta quella fretta, sempre, comunque, a qualsiasi ora, corrono al parco, in metro, dove devi lasciare la corsia di sorpasso a sinistra se non vuoi essere travolto, al contrario del traffico sonnolento fatto di Bentley e Aston Martin, che hanno tutto il tempo di farti attraversare, purché ti ricordi di guardare dal lato opposto rispetto al resto del mondo. È tutto unico, persino esclusivo, perché se hai una Mercedes o una Bmw sei un poveraccio rispetto alle loro case automobilistiche, perché un Range Rover non si nega a nessuno e le strade sembrano tutte appena asfaltate, non una buca, non una mattonella fuori posto in marciapiedi e camminate lungofiume che sono tutte uguali, senza partiture di rifacimenti successivi, senza una sola nota stonata di rifiuti o sporcizia. Si paga, sì, tutto questo si paga, anche la latrina automatica di fronte al piccolo ratto disegnato da Banksky sotto il Tamigi, trovato dopo alcune ore di un’emozionante caccia al tesoro fra strade e vicoli, da poterci acconciare di per sé un percorso turistico, ma la qualità che ne esita è più che sufficiente a ripagare i pound che volano via dalle tasche. Che poi a dire il vero non sono affatto tanti. Debbo sfatare due miti: 1) vedere Londra in quattro giorni è possibile, magari meglio con calzature sportive, ma è una full immersion automatica, in cui vedi il letto striminzito dell’albergo e ti lamenti della famigerata mancanza del bidet, in quelle poche ore di notte in cui ti comunque ti mancano talmente tanto Piccadilly e Leicester che te le ritrovi nei sogni; 2) Londra non è poi così cara, pagare due grigliate di degna qualità ed una bottiglia di Montepulciano (di scarsa qualità) con tanto di aggiunta di doppio contorno, circa 60 pound, mi ha fatto tornare alla mente un ristorante di Teramo, di cui non farò il nome e che per par condicio non vedrà più la mia presenza, in cui una sera qualunque ho dovuto lasciare 60 euro per un antipasto caldo, una tagliata, e qualche contorno aggiuntivo accompagnato da una bottiglia di Montepulciano (di decente qualità). Ora se per qualche assurdo volo pindarico, volessimo paragonare Teramo a Piccadilly Circus, spendere più o meno gli stessi soldi per mangiare più o meno le stesse cose, peraltro nel pub di un certo signor Jamie Oliver, credo sia difficile da comprendere per molti. Per non parlare poi delle catene, che ovviamente sono in grado di abbattere i prezzi e di offrire sandwich freschissimi, non con la banale mayonese, bensì con salsa di semi di chia, di cui ammetto lietamente l’ignoranza, ma se a farmelo scoprire è stato un fast-fooder che ha un punto vendita almeno in ogni fermata della metro, qualcosa di diverso rispetto alle tradizioni nostrane andrà pur evidenziato. Occhio poi a parlare italiano, se pensavo di utilizzarlo come codice per non essere capito, l’inflazione di giovanissimi compatrioti è talmente elevata, che alla prima balbuzie inglese, ti guardano con quella faccia a metà fra il comprensivo ed il deluso e ti dicono: “possiamo parlare in italiano”. Al che, un po’ di tristezza ti attanaglia, in primis per non esserti mai dedicato ad andare oltre lo scolastico “the pen is on the table” e un po’ perché vedere le nostre città svuotate della propulsione giovanile ed i quartieri di Londra stracolmi di startup dell’impresa italiana produce un grande avvilimento, come bere una Nastro Azzurro per far scendere il panino, perché ti dicono che è la più buona in bottiglia. Certo, tra una vetrina e l’altra non sfuggono gli annunci delle Estate Agency che sparano affitti da 800 a 2000 pound a settimana, sì a settimana non al mese, ma non ci trovo nulla di così raccapricciante se pensate agli stipendi medi ed al ventaglio di opportunità lavorative che offre una città del genere, dove di fatto la periferia non esiste, se non in una serie infinita di cantieri pronti a riqualificare e recuperare spazio per crescere ancora, persino la vecchia cara Battersea powerstation dove volavano i maiali dei miei adorati Pink Floyd, è oggi preda di una miriade di gru pronte a sfornare un altro sito di attrazione e di vita nella parte sud della città. Vabbè ma piove. No, cinque minuti ogni tanto e gli inglesi se ne fottono, anche perché vanno in t-shirt o solo con la giacca con qualunque temperatura e io non sono riuscito a reggere minimamente il confronto, nemmeno con qualche birra in corpo. Vabbè ma la cucina. Parliamone: aboliamo il fish and chips, che è di una pesantezza storica e forse serve proprio per affrontare il freddo, per il resto a forza di fare kilometri su kilometri a piedi, mi imbatto in Borough Market da dietro, appena passato un tunnel sul Bankside, lì dove c’è il Globe Theatre di Shakespeariana memoria, mi guida il naso da tirocinante gourmet verso qualcosa di buono, verso il paradiso all’improvviso. Centinaia di verdi bancarelle organizzatissime, pulizia inaspettata e tutto ciò che il mondo produce raccolto in un isolato, dove l’odore delle spezie in vendita, è il profumo di una donna elegante, raccolta tra mercati di carni, pesci, verdure e la loro gloriosa e benefica trasformazione in cibo da strada nella sua accezione paradisiaca. Gorgoglii e spandimenti di fumi da svenimento, l’incontro fra l’uomo e l’energia declinato per paese, per abitudine, ma soprattutto per gusto, quel gusto che ti fa tornare il giorno seguente e quello dopo ancora, come se volessi trasferire la tua vita lì, dove avresti tutto ciò che ti serve. Avevo portato un predellino virtuale nella mia valigia, perché cullavo il folle sogno di parlare ad Hyde Park, di raccontare quanto è bella la mia Teramo e invitare gli inglesi a venire a trovarci, ma l’ho richiuso, soprattutto nel mio cuore, perché che gli vuoi dire a chi offre Leonardo Da Vinci gratis, a chi ha tutti i sapori del mondo, a chi ha i soldi, le bellezze, il trambusto e la calma, il calcio, la birra, i trasporti, la sanità sul cellulare? Già che gli vuoi dire? Niente, potresti proporgli la qualità della vita di provincia, quel tutto raccolto che dovrebbe essere il nostro tratto distintivo e non lo è più da qualche secolo, da quando proprio Sir John Acton definiva Teramo l’Atene del Regno, quella culla culturale che ci rendeva la Londra d’Abruzzo (mi permetto di coniare questa neo-definizione) quel primeggiare sul resto dei paesi aprutini per competenze ma soprattutto per la cura della persona, quell’obiettivo che probabilmente abbiamo perso di vista, o cui abbiamo abdicato per mancanza di orgoglio, nel far sentire la nostra voce forte e alta. Quel predellino l’ho riportato con me, rientrando fra i pericoli di crollo della Teramo-mare e gli sbalzi di corrente elettrica per la pioggia, perché un giorno potrebbe servire, magari lungo il corso, per dire semplicemente che la Teramo del 2030 non ha bisogno di industrie e fabbriche, bensì di essere il paradigma della “welfare city” una vera e propria cittadella del benessere, dove il mercato coperto assomigli al Borough di Londra anziché ad un parcheggio con palazzi decadenti, dove il Manicomio assomigli alla Tate Modern anziché ad un rifugio per piccioni, dove la sanità sia pioniera del culto della persona anziché del campanile, ma chissà, forse anche questo è un folle sogno, a meno che non lo si faccia tutti insieme.