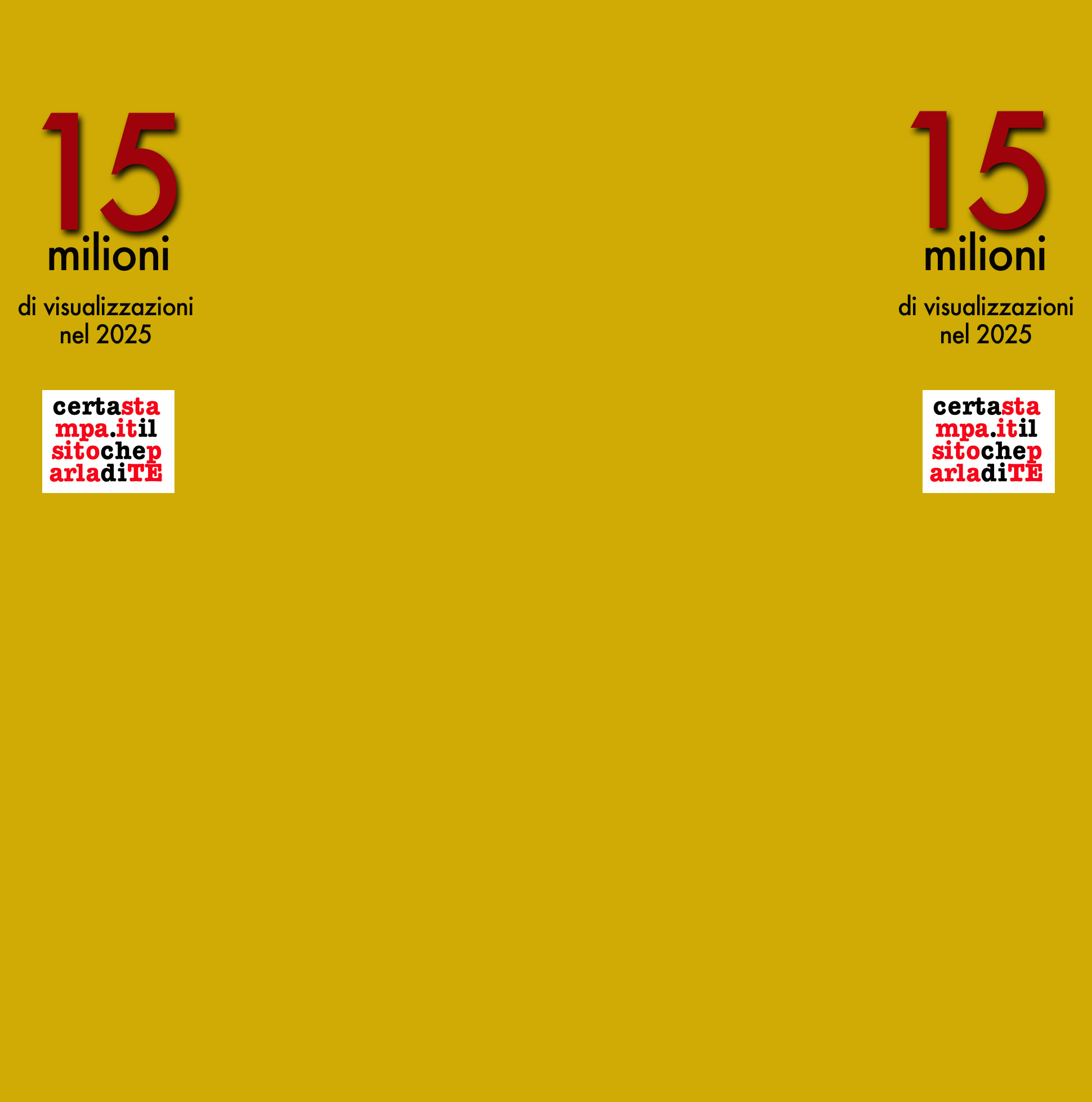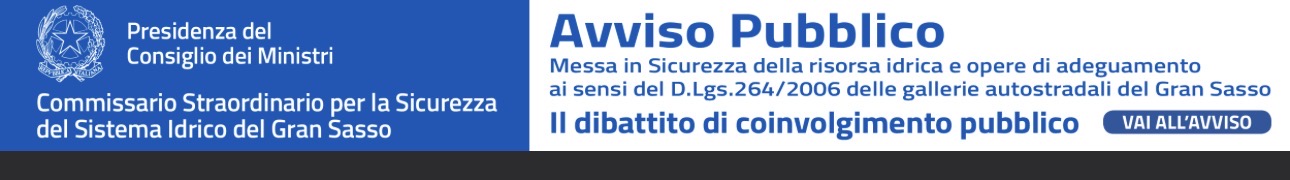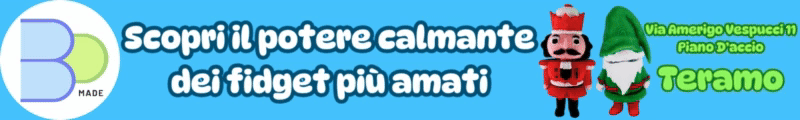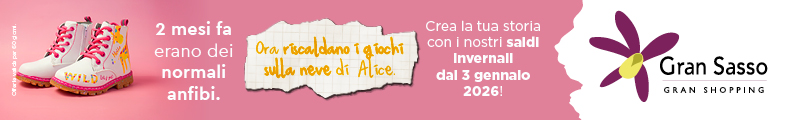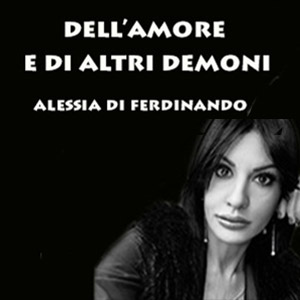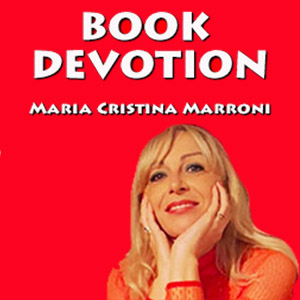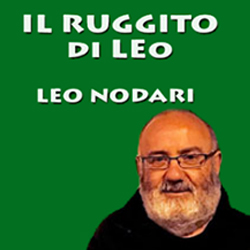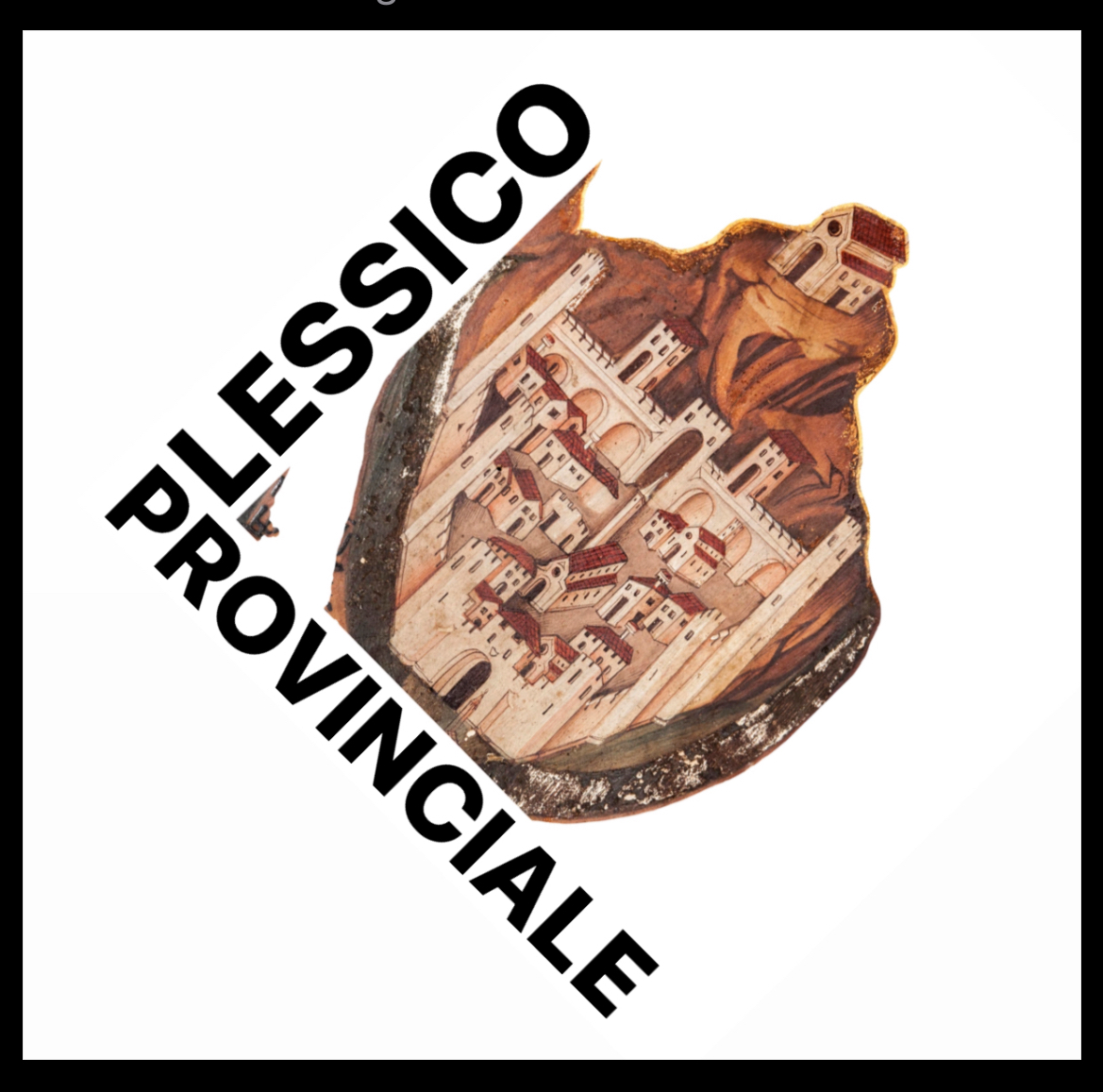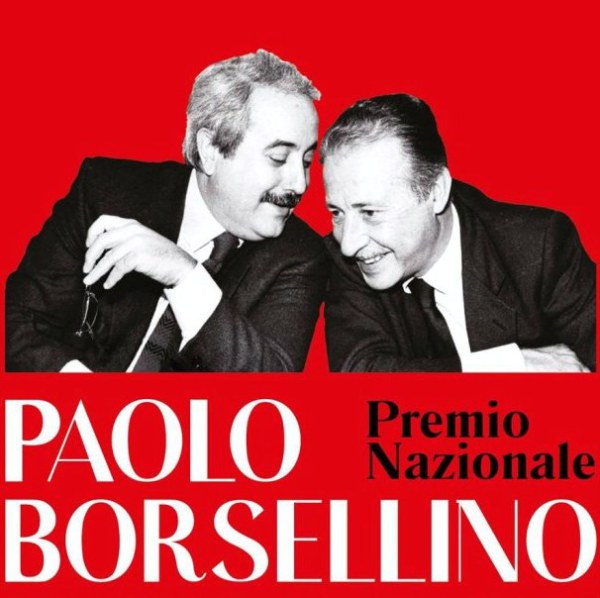Io c’ero. Avevo sei mesi. Il primo mio ricordo. Si può avere il ricordo di un fatto avvenuto quando si hanno solo sei mesi di età? Non so. Ma, poi, di quando quel giorno del maggio 1943 due aerei spuntarono all’improvviso da dietro il Monte Camicia e puntarono sullo stabilimento dellaSpica e presero a sganciare delle bombe se ne parlò spesso e a lungo in famiglia, anche perché il fratello di mia madre, che abitava al bivio di Villa Rossi, era uno dei due ragionieri della Spica. Ma perché quelle bombe, che mancarono la Spica e colpirono un luogo situato a poche centinaia di metri dallo stabilimento? Una delle quali, lo abbiamo saputo ieri, potrebbe essere caduta proprio su Castelli, per fortuna senza esplodere né quel giorno né nei tanti giorni successivi? L’ho raccontato nel mio libro “Sotto i cieli di Castelli. Il mio dove stetti fanciullo” (Artemia, 2016), di cui ripropongo due pagine.
Io c’ero. Avevo sei mesi. Il primo mio ricordo. Si può avere il ricordo di un fatto avvenuto quando si hanno solo sei mesi di età? Non so. Ma, poi, di quando quel giorno del maggio 1943 due aerei spuntarono all’improvviso da dietro il Monte Camicia e puntarono sullo stabilimento dellaSpica e presero a sganciare delle bombe se ne parlò spesso e a lungo in famiglia, anche perché il fratello di mia madre, che abitava al bivio di Villa Rossi, era uno dei due ragionieri della Spica. Ma perché quelle bombe, che mancarono la Spica e colpirono un luogo situato a poche centinaia di metri dallo stabilimento? Una delle quali, lo abbiamo saputo ieri, potrebbe essere caduta proprio su Castelli, per fortuna senza esplodere né quel giorno né nei tanti giorni successivi? L’ho raccontato nel mio libro “Sotto i cieli di Castelli. Il mio dove stetti fanciullo” (Artemia, 2016), di cui ripropongo due pagine.
Elso Simone Serpentini
“Il mio primo ricordo? Le bombe?A quale età possono risalire i primi ricordi? Intendo dire: è naturale che non si può conservare il ricordo, almeno riconosciuto e consapevole, dei primissimi mesi di vita. Solitamente si pensa che si possano avere ricordi, più o meno confusi o distinti, a partire da una certa età, da grandicelli. Io ho sempre ritenuto di aver conservato un ricordo di un particolare episodio avvenuto quando non avevo ancora compiuto un anno? E' possibile? C'è chi lo esclude.
E' da escludere anche se il ricordo riguarda un momento del tutto particolare, quale un bombardamento aereo? Quando ne ho parlato, nel corso degli anni, con i miei genitori, ho notato tanta incredulità e scetticismo. La loro spiegazione era che, siccome dell'episodio si era tanto parlato in casa, io dovevo aver conservato il ricordo di quel "parlare", non del bombardamento in sé. Adesso che i miei genitori non ci sono più, io continuo a credere, e non perché mi piaccia - o almeno non soltanto per questo - che nella mia memoria quei terribili momenti si impressero e vi rimasero scolpiti.
Non so precisare il determinato momento storico, vale a dire il mese, il giorno e l'ora in cui gli aerei nemici vennero a bombardare Castelli. Ma doveva essere il maggio del 1943, perché in famiglia mi dicevano cheio avevo sei mesi e sono nato il 7 novembre 1942. Ho nella memoria l'immagine di me, in braccio a mia madre, mentre in cielo sferravano gli aerei e si sentiva il rumore del bombardamento.
Ma perché il bombardamento a Castelli? Il faentino PotitoRandi, dopo un periodo di viaggi e di esperienze presso industrie europee e soprattutto tedesche, aveva assunto prima la direzione generale della Barbieri e Burzi di Bologna e poi, sempre a Bologna, dell'azienda Brevetti Baroncini, che fin dal 1920 produceva candele per aerei e autoveicoli. Quando lo stabilimento di quest'ultima ditta fu distrutto dai bombardamenti, si trasferì a Castelli, dove fondò la Spica (Società Prodotti Italiani Ceramici ed Affini), rilevando la vecchia Simac (Società Industriale Maioliche Abruzzesi Castelli) di proprietà della Brevetti Baroncini. La nuova azienda, che successivamente si avviò verso la produzione di stoviglie e di piastrelle per l'edilizia: pavimenti e rivestimenti, nonché di refrattari per forni di ceramica, inizialmente produsse candele per motori, anche di carri armati. [Randi, che era ebreo, riuscì a salvare molti ebrei dalla deportazione informando le autorità che la loro presenza era necessaria per produrre le candele di accensione]
Per impedire la prosecuzione di questa produzione tutt'affatto considerata "bellica", gli alleati anglo-americani [evidentemente informati dai partigiani italiani e slavi che si aggiravano nella zona] inviarono a Castelli alcuni aerei con il compito di bombardare la Spica. Ma sbagliarono il bersaglio e le bombe caddero a circa un chilometro di distanza, in una zona chiamata "li cretùne", da "creta", perché vi insisteva un sito di terreno argilloso, che veniva effettivamente usato dalla Spica, allora come in seguito, per l'estrazione dell'argilla. La qualità della terraglia non era eccelsa, tanto che poi l'uso ai fini di una produzione di stoviglie di pregio non proseguì, ma per altri fini meno "nobili" era conveniente, data la pochissima distanza dalla fabbrica, che faceva risparmiare cui costi di approvvigionamento della materia prima.
Il bombardamento de "li cretùne" rimase anche nella memoria collettiva dei castellani. Rimase anche nella mia, individuale, anche se sono il primo a stupirmene, considerato che all'epoca non avevo ancora compiuto un anno. Quelle candele che produceva la Spica e che continuò per qualche anno a produrre anche dopo la guerra, rimasero nella mia memoria anche per un altro episodio, avvenuto quando avevo cinque o sei anni.
All'epoca, nella parte bassa delle Casette, dove adesso è stato realizzato un doppio scivolo asfaltato per consentire alle automobili di salire dalla strada rotabile, inoltrarsi tra le case e portarsi nella piazzetta, c'era una scarpata erbosa con forte pendenza. Il dislivello tra la strada e il piano dove si trovavano le prime case era di un paio di metri. Era qui che io e i miei compagni ci dedicavamo, con grande divertimento, ad un gioco tanto semplice, quanto infantile, che chiamavamo "lulliscecacule". Infatti era uno scivolare con il sedere, lasciandoci andare dall'alto della scarpata al basso sull'erba che risultava così scivolosa da sembrare neve.
Un giorno, come avevo fatto tante altre volte in precedenza, presi la rincorsa e, arrivato sulla sommità della scarpata, mi lasciai andare, con il sedere sull'erba, scivolando alla maggiore velocità possibile. Avvertii a metà della discesa un forte dolore alla natica destra, una fitta terribile. Mi misi la mano sul sedere e la ritrassi tutta insanguinata. Qualcosa mi aveva trafitto i pantaloncini e mi aveva prodotto un buco profondo, dal quale sgorgava sangue in abbondanza.
A produrmi quella dolorosa e profonda ferita, che mi fu curata con amorevolezza e competenza dal medico Nicolino, a Castelli, dove i miei genitori mi portarono d'urgenza, era stata una candela della Spica. Fu rinvenuta e individuata come responsabile, con certezza, perché era tutta insanguinata. La ceramica era scheggiata dalla parte della punta in ferro che si trovava al centro dell'avvitatura. Era stata come una lancia appuntita che mi aveva perforato non appena ci ero scivolato sopra.
Non credo che sia stato questo secondo, doloroso episodio, a rafforzare (o a costruire artificiosamente) il ricordo del bombardamento, favorito dal collegamento fin tropo facile tra la candela che mi aveva ferito e le candele la cui fabbricazione gli aerei anglo-americani avevano l'intenzione, non riuscita, di interrompere con le bombe.
Ma chissà? Potrebbe anche essere...”