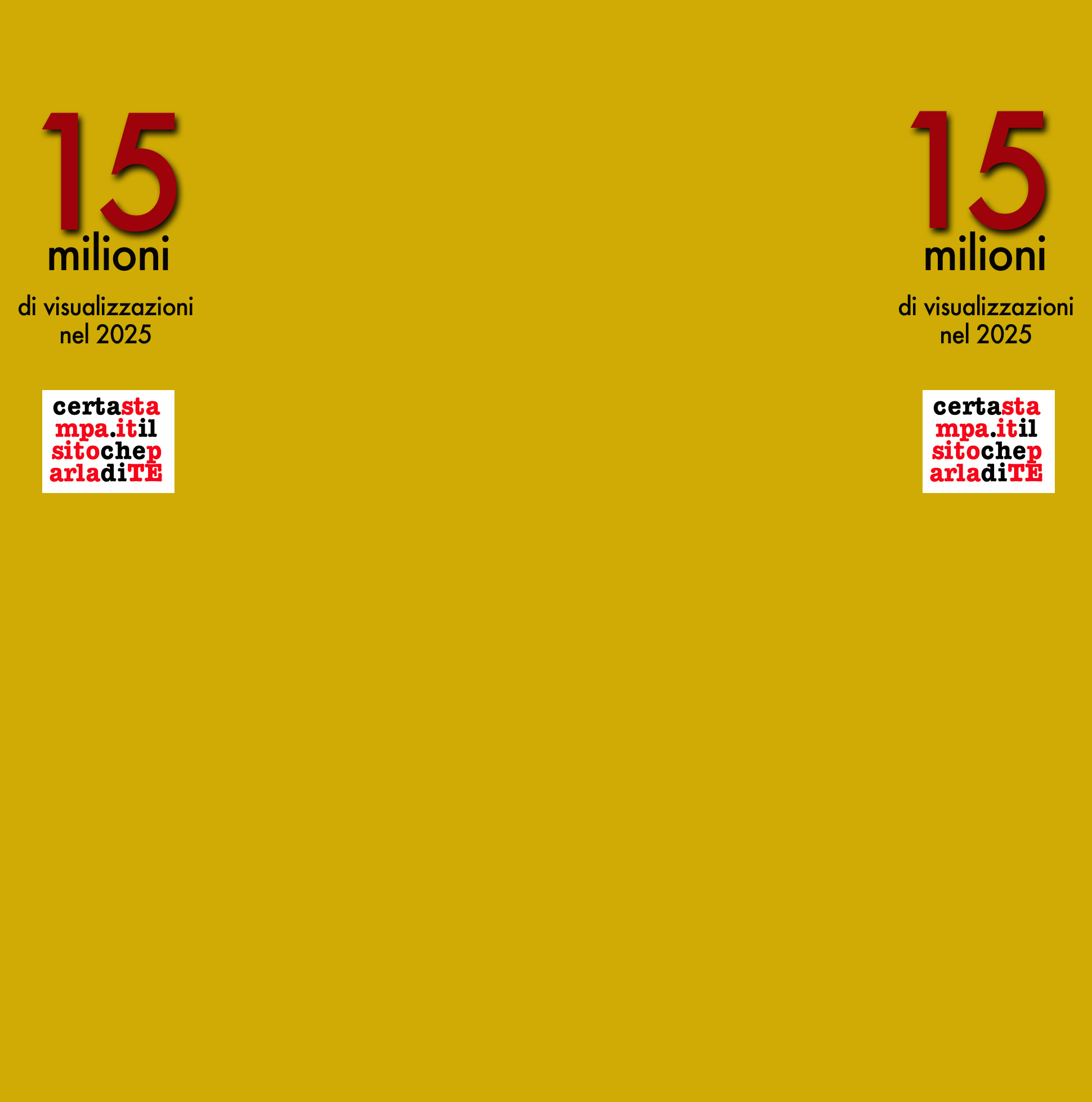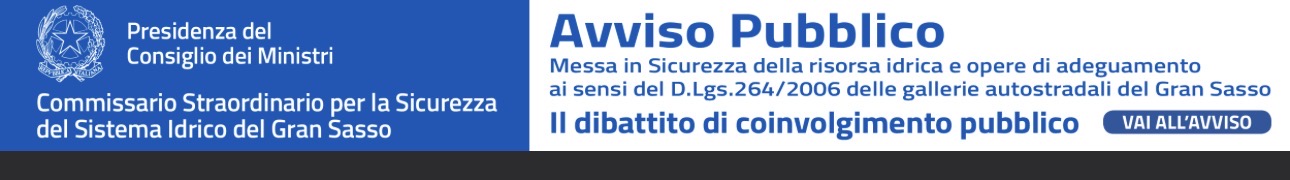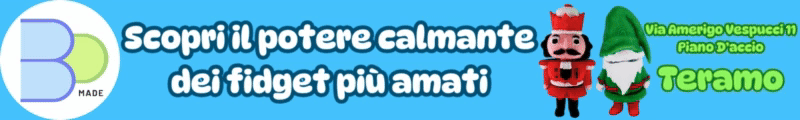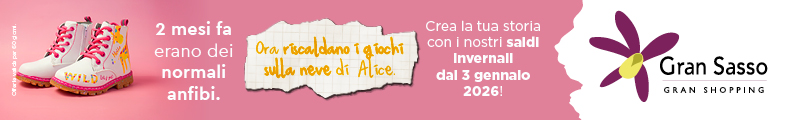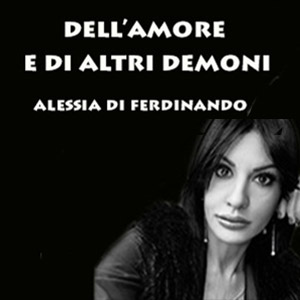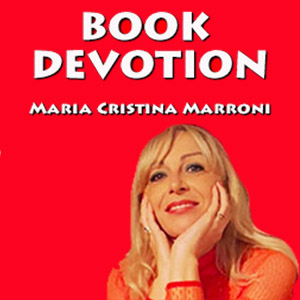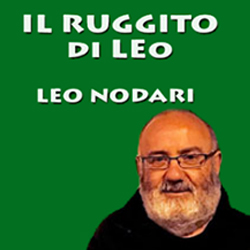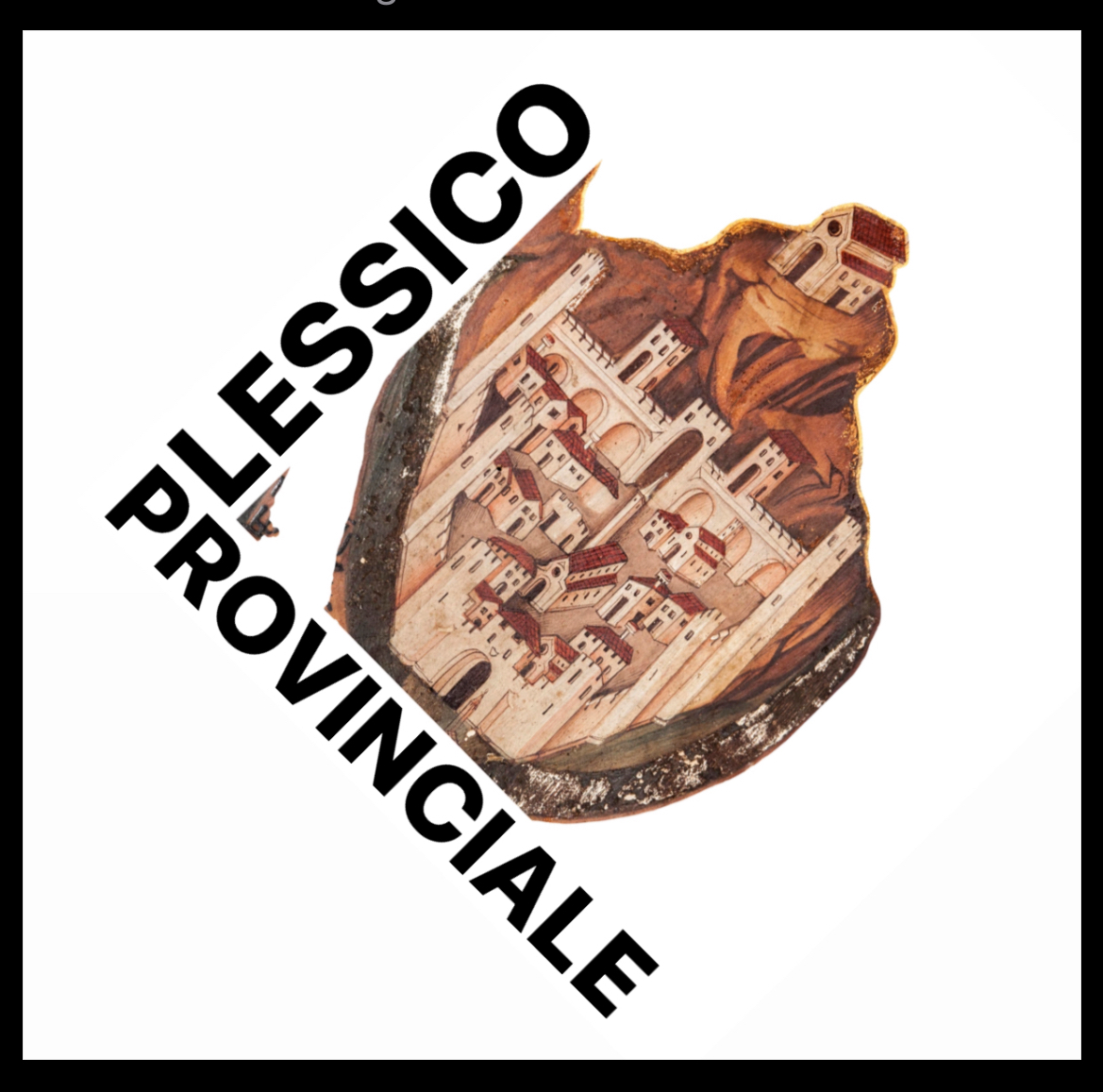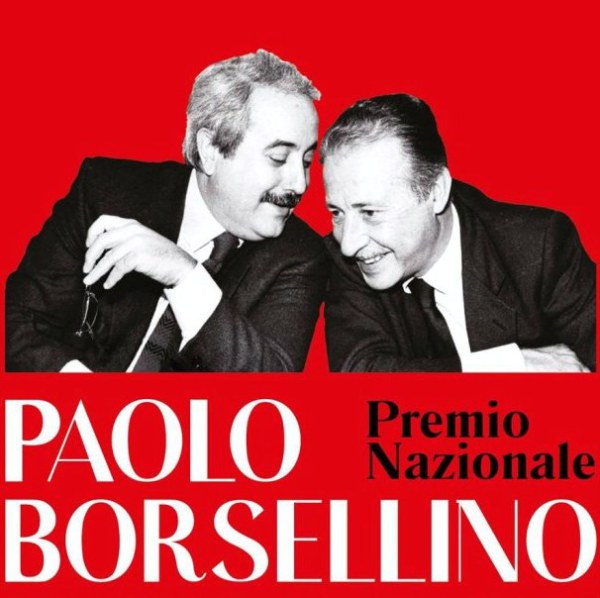Il 6 ottobre a Teramo si terrà un consiglio comunale straordinario per discutere il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aung San Suu Kyi, leader politica del Myanmar e premio Nobel per la Pace nel 1991. Verrà il figlio a ritirare l'onorificenza. Una decisione che, più che un atto simbolico di prestigio, rischia di trasformarsi però in una scelta controversa e divisiva. Per anni Suu Kyi è stata icona della resistenza non violenta contro la dittatura militare, diventando simbolo di democrazia e libertà nel mondo. Tuttavia, la sua immagine internazionale è stata profondamente incrinata dalla gestione della crisi dei Rohingya: la leader birmana è stata accusata di aver taciuto di fronte a violazioni sistematiche dei diritti umani, se non addirittura di averle giustificate. Diverse organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite ad Amnesty International, hanno più volte puntato il dito contro il suo atteggiamento. Quella dei Rohingya, in Birmania, è la storia di una delle popolazioni più perseguitate al mondo. Originari del Rakhine, territorio della Birmania occidentale al confine con il Bangladesh, sono di religione musulmana, e non sono riconosciuti da alcun Paese. In questa situazione, il Premio Nobel per la pace Aung San Suu kyi, dal 2016 Consigliera di Stato e alla guida del Ministero degli Esteri, ha sempre mantenuto una posizione ambigua sulla questione. Dopo le violenze del 2012 ha più volte evitato di parlare dei Rohingya nei discorsi ufficiali e nelle interviste, invitando semplicemente a “rispettare la legge e l’ordine” e rifiutandosi spesso anche di utilizzare il termine “Rohingya” - preferendo piuttosto definire i rifugiati come “bengalesi” o “musulmani”. Dal 2017, nonostante gli appelli di personalità come Desmond Tutu, che ha invitato Aung San Suu kyi a proteggere la minoranza musulmana (“un Paese che non protegge il suo popolo non è un Paese libero”), The Lady, così come la Consigliera è famosa, ha continuato a mostrare un atteggiamento contraddittorio, arrivando anche a revocare alla BBC il permesso di recarsi sui luoghi del conflitto. La missione indipendente istituita dalle Nazioni Unite nel marzo 2017 – che aveva il compito di fare luce sulle violenze – ha stabilito non solo che sono state commesse violazioni del diritto internazionale, ma anche che la leader birmana Aung San Suu Kyi "non ha usato la sua posizione di capo di fatto del governo, né la sua autorità morale, per contrastare o impedire lo svolgersi degli eventi nello stato di Rakhine". Tutto questo ha minato la stima internazionale del Premio Nobel per la pace, che ha visto revocarsi nel 2018 il premio “Ambasciatore della coscienza” conferitole nel 2009 da Amnesty International. In questo contesto, appare legittimo chiedersi quale sia il senso – e l’opportunità politica e morale – di attribuire oggi a Suu Kyi un’onorificenza così significativa. Non si tratta solo di una formalità: la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che riflette i valori e l’identità di una comunità. Cosa vuole dire Teramo con questa scelta? Vuole ricordare il mito della “donna contro i generali” o intende chiudere un occhio sul suo silenzio davanti a una tragedia umanitaria? La vicenda apre dunque un dibattito più ampio: fino a che punto le istituzioni locali dovrebbero tenere conto delle evoluzioni delle figure pubbliche che scelgono di onorare? Per la cronaca: Il 27 settembre 2018 il parlamento del Canada ha decretato, con votazione unanime, la revoca della sua cittadinanza onoraria canadese
Il 6 ottobre a Teramo si terrà un consiglio comunale straordinario per discutere il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aung San Suu Kyi, leader politica del Myanmar e premio Nobel per la Pace nel 1991. Verrà il figlio a ritirare l'onorificenza. Una decisione che, più che un atto simbolico di prestigio, rischia di trasformarsi però in una scelta controversa e divisiva. Per anni Suu Kyi è stata icona della resistenza non violenta contro la dittatura militare, diventando simbolo di democrazia e libertà nel mondo. Tuttavia, la sua immagine internazionale è stata profondamente incrinata dalla gestione della crisi dei Rohingya: la leader birmana è stata accusata di aver taciuto di fronte a violazioni sistematiche dei diritti umani, se non addirittura di averle giustificate. Diverse organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite ad Amnesty International, hanno più volte puntato il dito contro il suo atteggiamento. Quella dei Rohingya, in Birmania, è la storia di una delle popolazioni più perseguitate al mondo. Originari del Rakhine, territorio della Birmania occidentale al confine con il Bangladesh, sono di religione musulmana, e non sono riconosciuti da alcun Paese. In questa situazione, il Premio Nobel per la pace Aung San Suu kyi, dal 2016 Consigliera di Stato e alla guida del Ministero degli Esteri, ha sempre mantenuto una posizione ambigua sulla questione. Dopo le violenze del 2012 ha più volte evitato di parlare dei Rohingya nei discorsi ufficiali e nelle interviste, invitando semplicemente a “rispettare la legge e l’ordine” e rifiutandosi spesso anche di utilizzare il termine “Rohingya” - preferendo piuttosto definire i rifugiati come “bengalesi” o “musulmani”. Dal 2017, nonostante gli appelli di personalità come Desmond Tutu, che ha invitato Aung San Suu kyi a proteggere la minoranza musulmana (“un Paese che non protegge il suo popolo non è un Paese libero”), The Lady, così come la Consigliera è famosa, ha continuato a mostrare un atteggiamento contraddittorio, arrivando anche a revocare alla BBC il permesso di recarsi sui luoghi del conflitto. La missione indipendente istituita dalle Nazioni Unite nel marzo 2017 – che aveva il compito di fare luce sulle violenze – ha stabilito non solo che sono state commesse violazioni del diritto internazionale, ma anche che la leader birmana Aung San Suu Kyi "non ha usato la sua posizione di capo di fatto del governo, né la sua autorità morale, per contrastare o impedire lo svolgersi degli eventi nello stato di Rakhine". Tutto questo ha minato la stima internazionale del Premio Nobel per la pace, che ha visto revocarsi nel 2018 il premio “Ambasciatore della coscienza” conferitole nel 2009 da Amnesty International. In questo contesto, appare legittimo chiedersi quale sia il senso – e l’opportunità politica e morale – di attribuire oggi a Suu Kyi un’onorificenza così significativa. Non si tratta solo di una formalità: la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che riflette i valori e l’identità di una comunità. Cosa vuole dire Teramo con questa scelta? Vuole ricordare il mito della “donna contro i generali” o intende chiudere un occhio sul suo silenzio davanti a una tragedia umanitaria? La vicenda apre dunque un dibattito più ampio: fino a che punto le istituzioni locali dovrebbero tenere conto delle evoluzioni delle figure pubbliche che scelgono di onorare? Per la cronaca: Il 27 settembre 2018 il parlamento del Canada ha decretato, con votazione unanime, la revoca della sua cittadinanza onoraria canadese