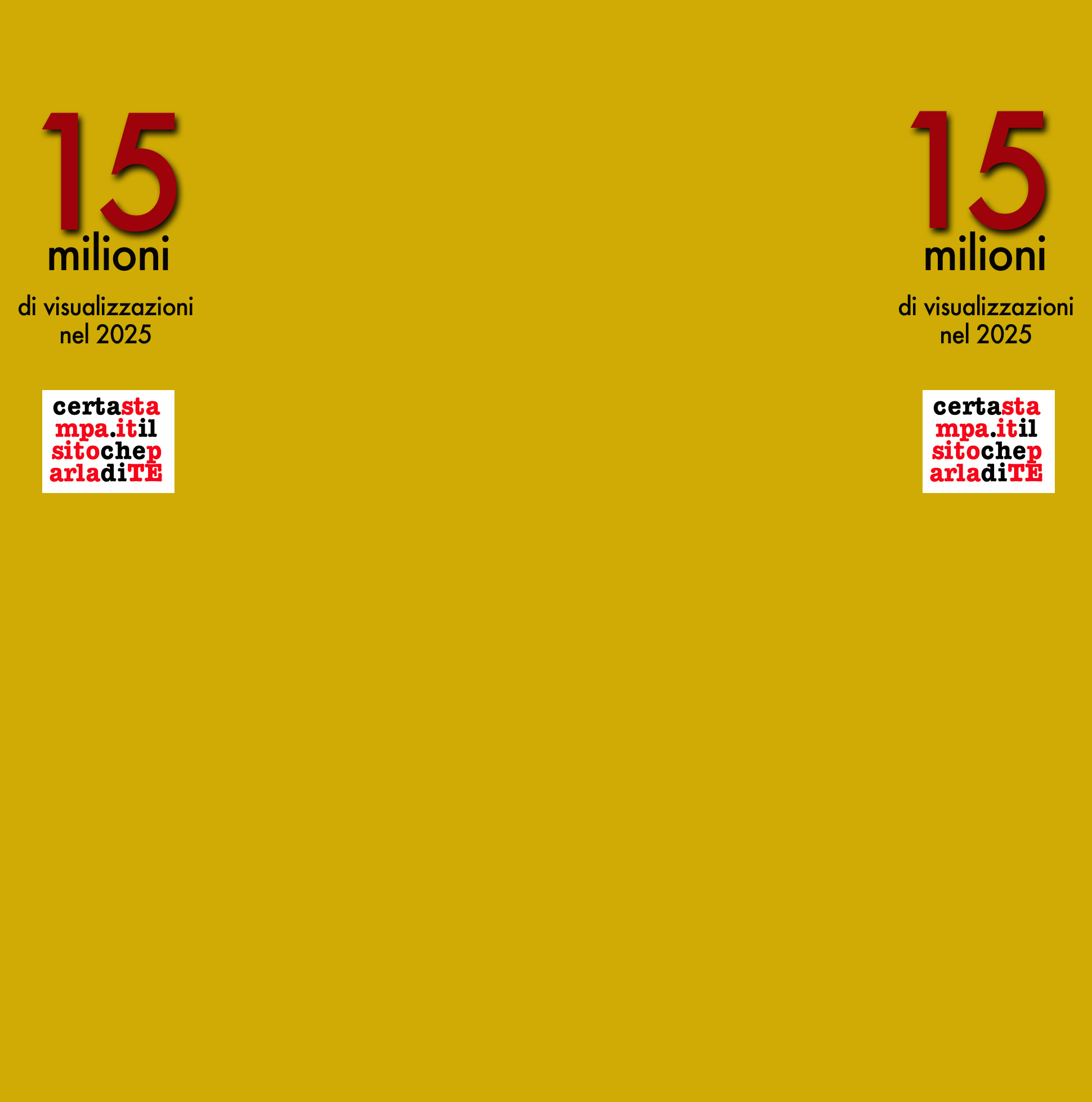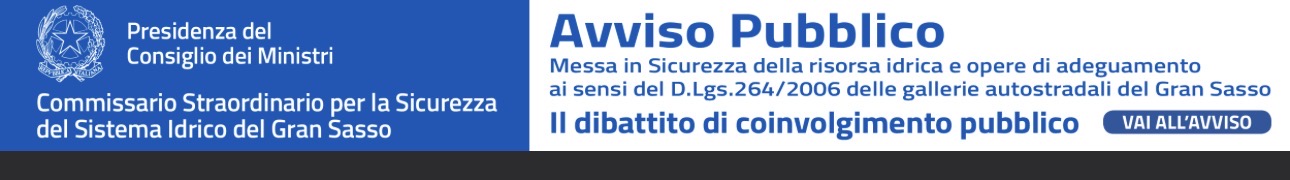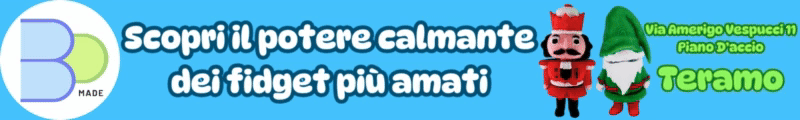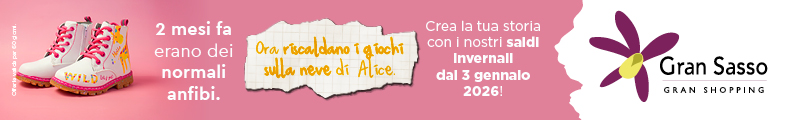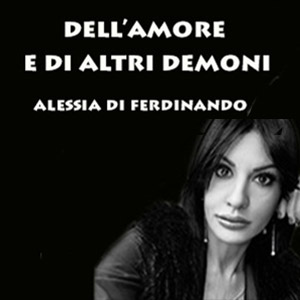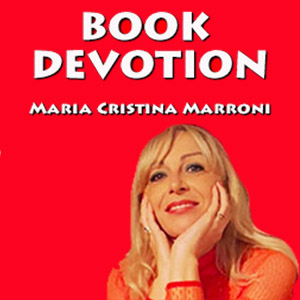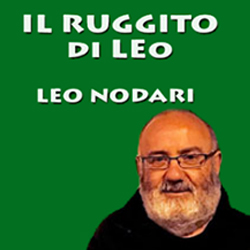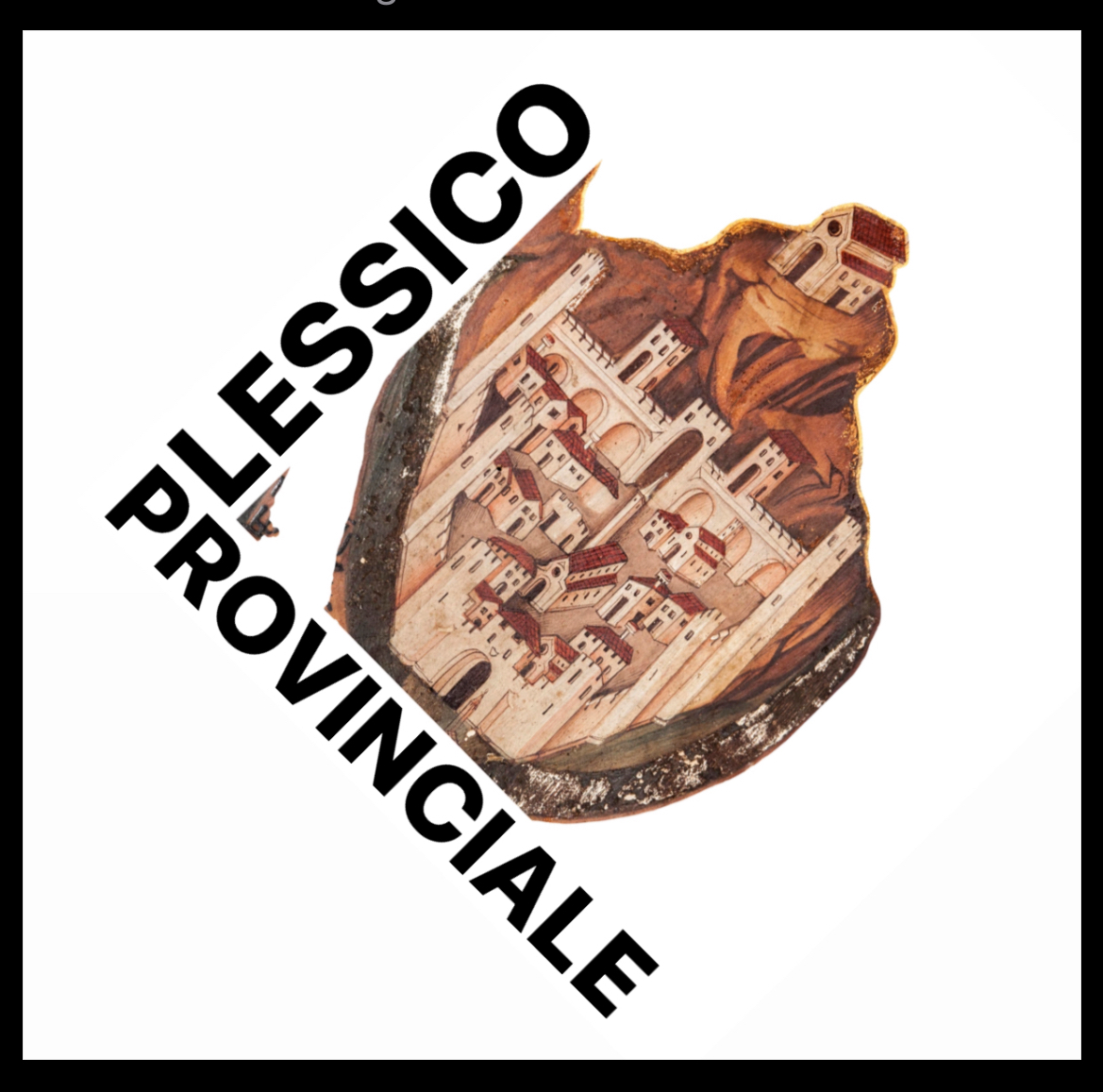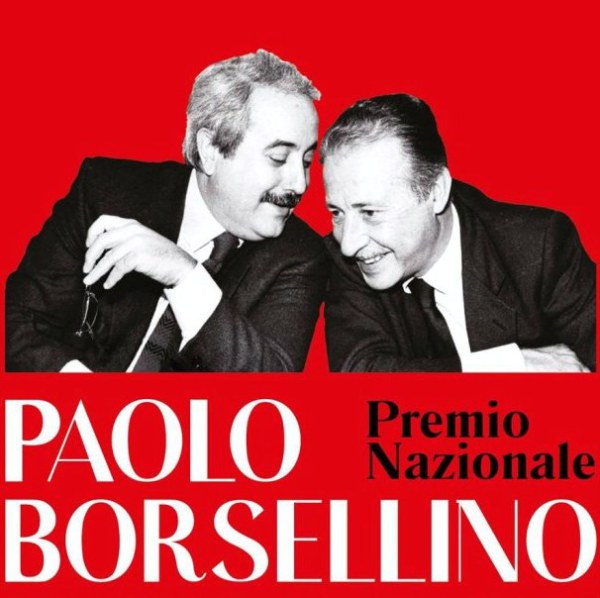Gennaro Finamore (Gessopalena, 11 agosto 1836 – Lanciano, 9 luglio 1923), nello studiare i canti popolari abruzzesi, scriveva che la facoltà poetica è essenzialmente muliebre, perché non ci sarebbe vita senza il sentimento, che è la fiamma a cui l’uomo si scalda, ma la cui ara è nel cuore della donna, e produce soprattutto canti d’amore, o quelli in cui prevale un motivo affettuoso. Però, diceva Finamore, il sentimento non nasce adulto e, prima di essere piena luce e massima vibrazione dell’essere umano, è aurora e quasi anticipazione di altre forme. Prima di concepire l’amore, che nel cuor umano crea il canto, in Abruzzo prima dei canti amorosi, espressione della canzone popolare, erano nati quelli fanciulleschi, che erano di due tipi: quelli che risuonavano nell’alba della vita, ed erano gai e sollazzevoli, non senza qualche nota mesta, e quelli nei quali erano raccolte le espressioni ritmiche eccitate dallo spettacolo della Natura.
Ai canti fanciulleschi erano seguiti i canti d’amore, nelle varie fasi e modulazioni e, come in tutti i canzonieri popolari, anche in Abruzzo erano quelli più numerosi. Ma molti erano anche i versi e i canti prodotti sempre più dalla fantasia e sempre meno dall’affetto. Erano stati creati dall’arte più che nati dall’abbondanza del sentimento d’amore e potevano essere classificati come narrativi, sentenziosi, satirici, scherzosi, relativi a mestieri o ad operazioni della vista campestre. C’erano poi i canti religiosi, che come quelli dettati dallo spettacolo della Natura, avevano assunto modi e forme che andavano dalle più rudimentali alle più complesse, e queste ultime si erano avute quando la spontaneità aveva ceduto all’arte. In quest’ultimo campo si registrava un’ampia gamma di ispirazioni: si andava dalle invocazioni e dalle formule ritmiche superstiziose a temi sempre meno naturalistici e più cristiani, consistenti in preghiere infantili, laudi, liriche e drammatiche, le leggende, fino ad arrivare a vere e propri componimenti sui santi patroni.
A questo quadro di riferimento Gennaro Finamore si ispirava nel classificare, ordinare e raggruppare i canti da lui raccolti sul campo, dalla viva voce del popolo, che trascriveva e tramandava, tenendo insieme quelli che esprimevano idee simili o affini e si presentavano o nella forma della “canzone” (il nome più comune del canto popolare abruzzese), o dello “stornello”, termine assai meno usato, che era in prevalenza scherzoso o a dispetto (in abruzzese “canzùne suspètte”).
Finamore metteva in risalto che in Abruzzo non c’erano mai state città o Corti che avessero irraggiato attorno a sé una potente azione civile, per cui anche nella produzione dei canti popolari avevano esercitato la loro funzione creativa i singoli comuni, restati in uno stato di reciproca indifferenza, pur in una oggettiva similarità di condizioni, più che dalle distanze, dalla mancanza o dalla insicurezza delle strade oltre che da barriere naturali come monti, boschi e fiumi. Era accaduto così che molto spesso era stata maggiore l’influenza dei principali centri di attrazione, sebbene lontani (Napoli, ma anche la campagna romana, le Puglie, la Marca di Ancona, colonie slave ed albanesi stabilitesi in qualche luogo), che quella della città abruzzesi, piccole e poco aristocratiche, nelle quali la vita municipale era condizionata e caratterizzata dal baronaggio, dal chiericato secolare e regolare, dal brigantaggio e quella quotidiana del popolo grama e stentata, per scarsi raccolti, pochissimo commercio, poca rimuneratività dei mestieri e delle arti, povere e rozze, sì che in un ambiente avverso l’unica oasi benigna a protezione delle ostilità era la casa. Erano state le mura domestiche a custodire l’eredità dell’indole, del costume, delle tradizioni e a difendere da intrusioni esterne. I canti erano quelli dei coscritti alle loro belle, delle donne che si allontanavano come spose dal tetto paterno, dei frizzi, spesso pungentissimi espressi anche in proverbi e detti, in novelle, contro monaci e preti. I maggiori contatti con altre province, campagna romana e Puglie, erano avvenuti tramite agricoltori e pastori che vi si erano trasferiti ed essi avevano portato ad uno scambio a ad una assimilazione di temi dei canti popolari, temi importati altrettanto spesso che esportati.

Le principali depositarie dei canti popolari, secondo Finamore, erano state le donne, in mancanza di poeti e cantastorie di professione. In tutti i comuni abruzzesi non erano mancate persone del popolo, non sempre illetterate, che sapevano a memoria i canti e li avevano tramandati oralmente, sia le serenate che i canti fanciulleschi e religiosi, ma la maggior parte di loro erano amorosi, narrativi e leggendari e le maggiori depositarie ne erano state le donne, cantatrici instancabili sia tra le mura domestiche sia nell’attendere ai lavori campestri. Scriveva Finamore: “Le nostre contadine sono cantatrici indefesse. Cantano presso la culla e presso la tomba, in casa e all’aperto, lavorando, tacendo, pensando. Laboriosissime, frugali, bevono acqua e s’inebriano di canto. Direbbesi che la prosa sia l’eccezione della loro vita: che serva a posare in terra quanto è mestieri; e il canto l’ala che batte continuo a sollevarne l’anima dalla misera realtà. Nondimeno sono restie a dettare i loro canti; quasi che un senso di pudore le trattenesse dallo scoprire a’ profani la parte più gelosa ed intima di se stesse”.
Finamore riscontrava una infiltrazione dell’elemento letterario nei canti popolari abruzzesi, in prevalenza negli uomini guidatori delle serenate che attingevano dalla raccolte oltre che dalla tradizione orale, e in moltissimi dei loro canti la provenienza letteraria saltava agli occhi. Le donne, invece, avevano fatto propri i prodotti letterari e forestieri limitatamente a ciò che risultava più spontaneo e conforme al genio popolare. Finamore avvertiva che chi avesse voluto attingere alla fonte viva della canzone popolare abruzzese non avrebbe dovuto stare troppo a sentire qualche uomo che, mietitore, pastore o mestierante, avesse bazzicato in Puglia, a Napoli o nell’agro romano, o le donne di città, ma avrebbe dovuto sentire le donne attempate, rimaste sempre nelle campagne dei comuni più piccoli e meno noti, dove era rimasta quella vena di poesia schietta e limpida in cui, nel volgere del tempo, gli elementi esterni si erano depositati sul fondo ed erano diventati indiscernibili nell’alveo comune. Tutto questo aveva creato una comune cultura, tanto che, osserva Finamore, accadeva spesso che ad una contadina bastava cantare il primo verso di una strofa del suo comune per sentire continuare il secondo verso dalla contadina di un comune anche un po’ lontano.
Tuttavia chi non era abruzzese, osservava ancora Finamore, poteva trovare inverosimile che molti canti anche di comuni non limitrofi fossero comuni e poteva essere tentato di attribuire ad essi una derivazione colta. Non era da escludere che, non poeti popolari in senso stretto, ma semplici versificatori in dialetto, avessero raccolto e tradotto canti del popolo nei quali era presente un’eco della vita passata, ma ordinariamente autore del canto era stata una persona del volgo e al motivo originale, talvolta di poche strofe, se ne erano aggiunte altre, per collaborazione anonima, fino a diventare una filastrocca ripetuta continuamente fino a sazietà. Questo faceva sì, concludeva Finamore, che la ricerca documentaria sui canti popolari abruzzesi si presentasse difficile e laboriosa, più di quanto potesse credersi e chiunque avesse voluto porvi mano necessariamente avrebbe dovuto fare appello alla collaborazione e al patriottismo di molti corregionarii.
Elso Simone Serpentini