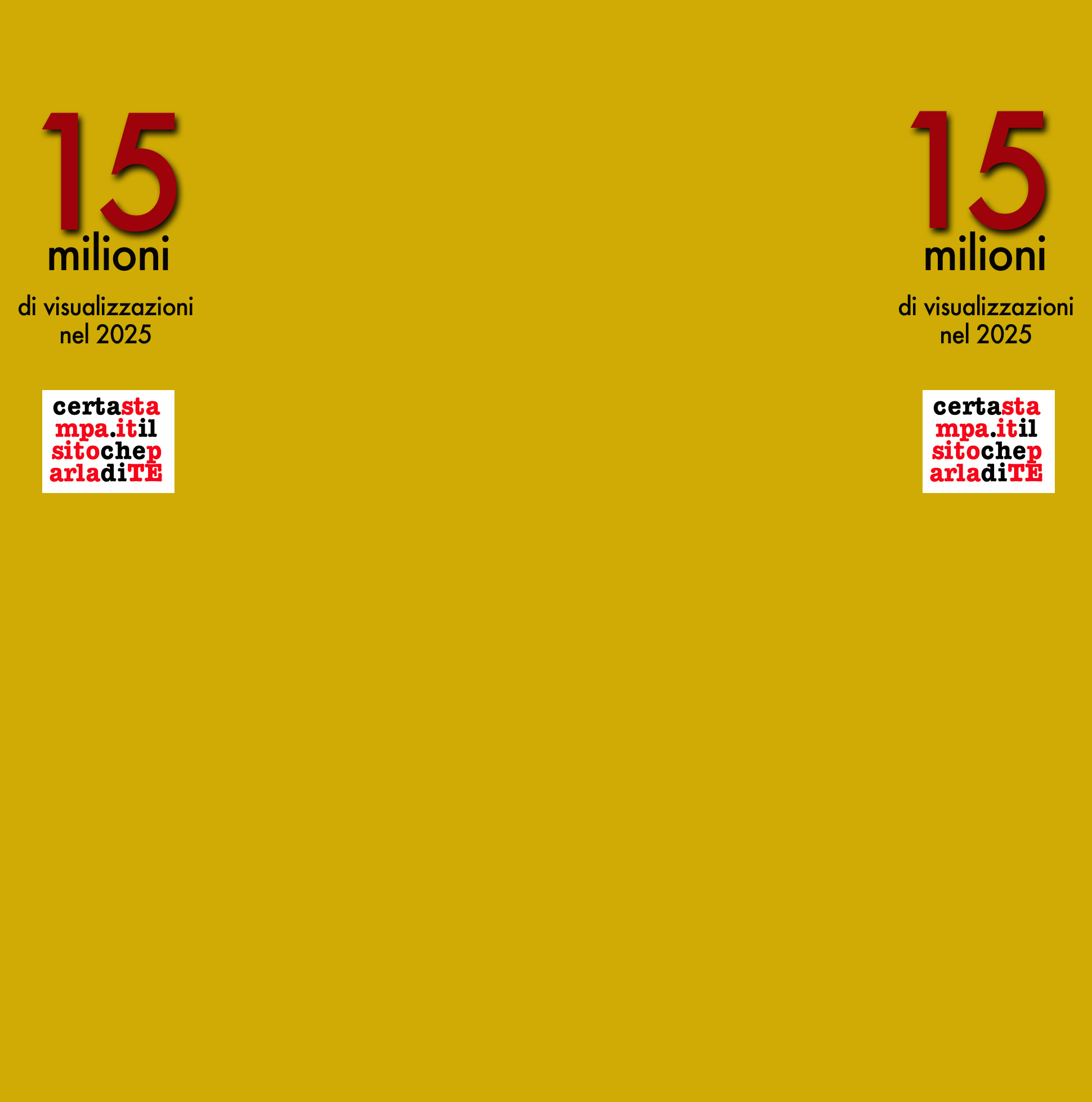Non dovrebbe fare rumore.
Non dovrebbe fare rumore.
Non dovrebbe pretendere attenzioni, né reclamare un titolo in cronaca, tantomeno un editoriale.
È un oggetto nato per stare al centro di una tavola e sparire senza lasciare traccia: una formaggera. Una tettuccio mobile di metallo lucido, una pancia trasparente, un cucchiaino. Il regno minuto del Parmigiano, la polvere buona che cade come neve domestica.
Eppure qui, a Prato Selva, la formaggera fa rumore eccome.
Fa il rumore dell’abbandono.
È rimasta sul bancone del bar – quello che era il bar dell’albergo – come una sentinella dimenticata. Dentro, qualche residuo di Parmigiano: briciole stanche, granelli induriti, l’ultima traccia di un gesto normale. Un gesto che in montagna è più che normale: è sacro. Una pasta fumante dopo una mattina sugli sci, le mani rosse dal freddo, le guance accese, la fame che non è solo fame ma felicità, la felicità grezza, contadina e gentile, che ti fa dire “ancora un po’”.
La formaggera è rimasta lì.
Undici anni.
Undici anni: un tempo che basta per far crescere un figlio, per cambiare un paese, per dimenticare una promessa. Undici anni in cui un luogo può morire due volte: la prima quando chiude, la seconda quando smettiamo di parlarne come se fosse vivo.
Intorno, la devastazione.
Non quella romantica delle rovine che piacciono ai fotografi. No: devastazione vera, che sa di vandalizzazione e incuria, di vetri rotti e pareti graffiate, di segni lasciati da chi entra non per ricordare ma per prendere a calci quel che resta. Devastazione che non è una fatalità, ma un progetto rovesciato: il progetto del disinteresse.
Eppure Prato Selva non era una cartolina: era una voce.
Una voce teramana.
Non la neve “nobile” di Prati di Tivo – più alta, più famosa, più vendibile – ma quella più vicina al cuore. Quella che ti perdonava le piste corte, perché ti regalava la prima volta. La prima sciata di generazioni di bambini: cadute e risate, ginocchia sbucciate sotto la tuta, guanti persi e ritrovati, maestri con la pazienza degli alberi. La montagna come educazione sentimentale: imparare la paura e superarla, imparare l’equilibrio, imparare che si può scendere anche quando sembra impossibile.
Prato Selva era l’inizio, non il lusso.
E per questo, forse, era più importante.
Ora, invece, è uno spettrale monumento alle occasioni perdute. Non un rudere: un’accusa. Sta lì a dire che in Abruzzo – e non solo – sappiamo fare turismo di parole. Turismo di conferenze, piani, annunci, post, slogan. Turismo di tavoli tecnici e foto con lo sfondo giusto, mentre davanti il presente cade a pezzi. Un turismo che “ripartirà”, che “rilancerà”, che “valorizzerà”: verbi bellissimi, sempre al futuro. Il turismo come grammatica della scusa.
E la formaggera, sul bancone, diventa simbolo senza volerlo.
Perché dentro non c’è solo Parmigiano.
C’è la polvere di una comunità che si è disabituata a pretendere. C’è la cenere sottile di un’identità svenduta a rate. C’è il residuo di un calore che non si è trasformato in progetto.
La formaggera è un oggetto piccolo che contiene una cosa grande: la prova che qui, un tempo, la normalità funzionava. E che oggi la normalità è diventata miracolo.
Undici anni.
Undici anni in cui nessuno ha aperto quella formaggera. Nessuno ha pulito quel bancone. Nessuno ha restituito dignità a quel bar. E allora la domanda diventa una colpa collettiva: come si fa a lasciare così a lungo una cosa così semplice?
Perché l’abbandono non comincia con i grandi crolli.
Comincia con il dettaglio che smetti di vedere.
Con la serranda che resta chiusa “solo per questa stagione”.
Con la toppa provvisoria.
Con il cartello sbiadito.
Con l’idea che qualcuno, prima o poi, se ne occuperà.
E invece non se ne occupa nessuno.
C’è una crudeltà particolare, a Prato Selva.
Non è solo la chiusura.
È il silenzio colpevole che le è cresciuto intorno, come muffa. Un silenzio che assolve i responsabili, che anestetizza l’indignazione, che trasforma la ferita in abitudine. È l’Italia delle stazioni sciistiche lasciate indietro, dei paesi che diventano “problemi” invece che risorse, dei luoghi che esistono solo quando servono come sfondo elettorale o nostalgia da bar.
Qui, però, è tutto chiuso davvero.
E sul bancone resta una formaggera.
Se la guardi bene, quella scatoletta trasparente sembra un globo.
Un mondo in miniatura.
Dentro c’è un’ultima neve gialla – Parmigiano secco, grani fermi – e sembra dirci che la neve vera, quella fuori, non è sparita per mancanza di fiocchi ma per mancanza di coraggio. Perché la montagna non chiede miracoli: chiede attenzione. Chiede manutenzione, visione, costanza. Chiede la cosa più difficile in Italia: continuità.
Ed eccolo, allora, il vero monumento.
Non una statua, non una targa, non un “qui sorgeva”.
Una formaggera abbandonata.
In un mondo serio, quel residuo di Parmigiano sarebbe una sciocchezza. Si toglierebbe in un attimo, si pulirebbe con una spugna. Fine.
Qui diventa un’epigrafe.
Scrive senza inchiostro: avevamo un posto, e l’abbiamo lasciato andare.
Scrive: eravamo capaci di fare famiglia attorno a una pista.
Scrive: la memoria non basta, se non diventa responsabilità.
E allora sì, vale un editoriale.
Perché certe volte la verità non si presenta con i grandi discorsi: si posa, in silenzio, sul bancone di un bar chiuso.
E aspetta che qualcuno la guardi negli occhi.
E, partendo da quella riconsegna di ieri mattina, scriva una nuova storia.
E torni il tempo in cui una formaggera accompagni le risate dei giorni felici e delle prime sciate.
In una montagna ritrovata.
E di nuovo nostra.
EdC